Paola Falchi, Matteo Milletti, Le “faretrine” nuragiche. Considerazioni sulle modalità di contatto tra Sardegna ed Etruria nei secoli iniziali del primo millennio a.C.
Estratto dal fascicolo 61-62 (gennaio-giugno 2024)
Le cosiddette “faretrine” rappresentano una delle più peculiari fogge dell’articolato repertorio di pendenti nuragici. Il loro nome, invalso in letteratura già della fine del XIX secolo, deriva dalla somiglianza con una faretra da frecce: in realtà questi bronzetti raffigurano una guaina a doppia tasca, contenente su di un lato un pugnale e, su quello opposto, da uno a quattro spilloni, o più raramente un secondo stocco, con il sistema di sospensione costituito generalmente da due anelli affiancati su uno dei lati lunghi. I nostri pendenti rappresentano un caratteristico modo di portare le armi, tipico delle genti nuragiche: alcune statuine antropomorfe mostrano infatti come questi foderi venissero portati sul petto, con il pugnale pronto all’estrazione, fissati su una bandoliera trasversale. L’interesse per le faretrine, oggetti dunque dall’alto valore ideologico, deriva in effetti, oltre che dalla loro unicità nel panorama delle tradizioni bronzistiche mediterranee coeve, anche dalla fedeltà delle rappresentazioni sui due lati, che in alcuni casi consentono l’esatta identificazione degli oggetti reali, spilloni e pugnali. In questa sede si intende dunque proporre, oltre ad una messa a punto della sequenza tipologica e a considerazioni di carattere tecnico sulle faretrine, alcune riflessioni sulle motivazioni che si ritiene siano alla base dell’arrivo di manufatti nuragici sulla penisola nella prima età del Ferro: la diffusa circolazione di bronzetti sardi nell’Etruria settentrionale tirrenica e la loro frequente deposizione tra i selezionati oggetti che compongono i palinsesti funebri, sono infatti la testimonianza materiale di fenomeni sociali complessi, da leggersi alla luce delle peculiarità delle comunità coinvolte. Le due compagini in esame, quella nuragica e quella etrusca, sembrano infatti caratterizzate, nei secoli in questione, da una diversa organizzazione sociale, incentrata però in entrambe le realtà su famiglie in senso allargato, al vertice delle quali porre personalità eminenti: la gestione dei contatti con interlocutori esogeni sarebbe in quest’ottica frammentata e affidata a rapporti interpersonali e privilegiati, con modalità simili alla πρῆξις omerica. Nel caso specifico, si tratterà dunque d’indagare l’insieme dei comportamenti ritualizzati e delle norme che dovevano regolare i rapporti tra le comunità in esame o, meglio, tra i rispettivi segmenti emergenti. Uno dei motori di questi rapporti era la cosiddetta “economia della gratitudine”, ovvero lo scambio di doni ospitali. Il probabile accoglimento di genti etrusche in terra sarda — sembrano suggerirlo i recenti rinvenimenti di Tavolara — impone infatti di interrogarsi sull’esistenza di particolari forme di xenìa tra le due compagini, nonché sulla consapevolezza della propria identità etnica da parte di queste ultime, con il connesso ruolo di potenziali marcatori svolto da alcuni oggetti ideologicamente significanti quali appunto le faretrine, in tale specifico senso o come semplici testimonianze di rapporti privilegiati, magari risalenti di generazioni.
Nuragic “faretrine”. Considerations on contact between Sardinia and Etruria in the early centuries
of the first millennium BCE
Faretrine pendants give us an insight into how Nuragic warriors may have armed themselves for battle. On some statuettes the faretrine are carried across the chest, strapped to the waist, dagger at the ready. Interest in faretrine pendants isn’t confined to their high ideological value, or their uniqueness amongst other bronze items being produced in the Mediterranean World at the time. They also provide us with a perfect replica of what was carried in that twin sheath, be it a stiletto blade or dagger.
This paper provides a honed down typological sequence for faretrine, as well as some technical considerations. It also reflects on why Nuragic artefacts were to be found on the Italian peninsula during the Early Iron Age. Quiver pendants and other Sardinian bronze objects are widespread throughout northern Tyrrhenian Etruria and are frequently to be found among the choice of grave goods. They are material evidence of a complex social phenomena, seen in the light of the idiosyncrasies of the two communities involved, Nuragic and the Etruscan. The two societies, over the centuries in question, seem to have been organised differently; but both revolved around extended families, governed by eminent personalities. Any contact with the outside world would have been via these privileged individuals, from their fragmented, personal and privileged outlook, as opposed to the heterogeneous vision of the societies they represented. The situation was similar to Homeric prāxis (action or negotiation). Here, we need to look at what ritual customs and behaviour lay behind relationships within these two societies, or at least between those in charge. At the heart of it was a self–styled “economy of gratitude”, an exchange of gifts, much like visiting cards. Recent discoveries in Tavolara would seem to imply that the Etruscans spread overseas to Sardinia. This would raise the question as to whether there were any particular forms of xenìa (ritual hospitality) between the two groups, as well as the extent to which each was aware of its own ethnic identity. Objects like the quiver pendants may have been ideologically significant beacons of this identity. On the other hand, they may be seen simply as evidence of long–standing, possibly intergenerational, privileged relationships.
Ultimo aggiornamento
7 Agosto 2025, 11:01
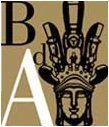 BOLLETTINO D'ARTE
BOLLETTINO D'ARTE